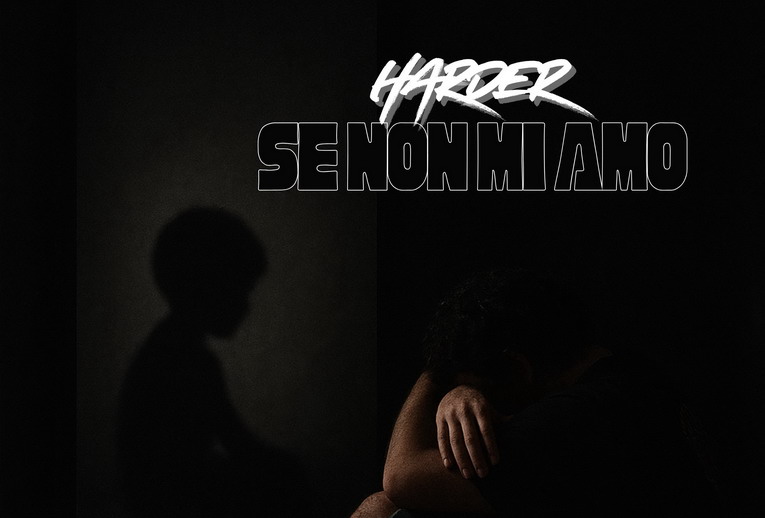Si è spento oggi, nella sua Napoli, Roberto De Simone, figura monumentale della cultura italiana, genio instancabile che ha consacrato la propria esistenza alla riscoperta, tutela e valorizzazione delle radici popolari del Mezzogiorno. Aveva 91 anni. Una vita lunga, densa di opere, battaglie culturali e amore viscerale per quella terra che non ha mai smesso di raccontare.
Era più di un musicista, più di un regista, più di un etnomusicologo. Era un ponte vivente tra l’oralità dei vicoli e la sacralità del palcoscenico. De Simone ha saputo fondere passato e presente, rito e innovazione, dando voce a quella Napoli profonda che spesso resta inascoltata, nascosta tra i muri scrostati e le melodie antiche delle sue corti.
Roberto De Simone, le origini di un’anima inquieta
Nato nel cuore di Napoli il 25 agosto 1933, De Simone si forma tra le austere aule del Conservatorio San Pietro a Majella, diplomandosi in pianoforte e composizione. Ma la sua fame di conoscenza va ben oltre le note scritte. Presto si appassiona al mondo contadino, alla ritualità del Sud, alle voci dimenticate dei canti di fatica, delle tammurriate, delle nenie. È un richiamo ancestrale, quello che lo porterà lontano dalle luci convenzionali della musica colta, per abbracciare con ardore il cuore pulsante della tradizione.
Il risveglio del canto popolare
Nel 1967 dà vita a un progetto visionario: la Nuova Compagnia di Canto Popolare. Non è solo un ensemble musicale, ma un laboratorio culturale, un atto d’amore verso un’identità che rischiava l’oblio. De Simone ricerca, trascrive, reinventa. Salva, letteralmente, una parte d’Italia che si stava spegnendo sotto il peso della modernità.
Con la NCCP, De Simone porta la voce dei contadini, dei pescatori, delle madri meridionali sui più importanti palcoscenici d’Italia e d’Europa. Quella voce, fino ad allora confinata nelle feste patronali e nei matrimoni, diventa finalmente arte riconosciuta, degna dei teatri e delle stagioni liriche.
La Gatta Cenerentola: quando il mito torna a parlare
Nel 1976 arriva l’opera che lo consacra: La Gatta Cenerentola. Un capolavoro assoluto, in cui la favola partenopea diventa tragedia popolare, affresco teatrale, poema sonoro. De Simone, con intuizione folgorante, mescola dialetto e barocco, canto a fronna e teatro d’avanguardia. Il risultato è potente, emozionante, rivoluzionario. Lo spettacolo trionfa al Festival di Spoleto e conquista l’Italia intera.
Ma il successo non lo allontana dalla sua missione. Al contrario. Più viene acclamato, più si sente responsabile di quel patrimonio immateriale che continua a esplorare con passione da antropologo e cuore da poeta.
Un uomo, mille vite
Nel corso degli anni, De Simone ha vestito ruoli istituzionali di grande rilievo, portando la sua visione in ambienti accademici e direttivi: direttore artistico del Teatro San Carlo, guida illuminata del Conservatorio di Napoli. Ma mai burocrate, mai compromesso. Sempre libero, sempre radicale nel suo pensiero, profondamente consapevole che la cultura non è ornamento, ma radice, necessità, riscatto.
La sua voce, ferma e gentile, ha guidato generazioni di musicisti, attori, studiosi. Il suo pensiero ha scavato nella memoria collettiva, facendo emergere antiche ferite e nuove speranze. I suoi insegnamenti, scritti e orali, continueranno a vibrare nei cori popolari, nei tamburi di festa, nei passi delle processioni.
L’eredità di un gigante
Oggi l’Italia perde uno dei suoi più grandi testimoni del ‘900. Non un nostalgico del folklore, ma un profeta della memoria. Non un archivista, ma un artista che ha saputo rianimare il passato per costruire un presente più consapevole. In un tempo che spesso dimentica le proprie radici, Roberto De Simone ci ha insegnato ad ascoltarle, a cantarle, a difenderle.
Le sue opere, le sue registrazioni, i suoi scritti restano. Ma soprattutto restano le sue idee, la sua capacità di far dialogare il sacro e il profano, il colto e il popolare, il teatro e la piazza. Napoli lo piange come un figlio devoto, l’Italia lo saluta come un maestro.
E mentre le campane del Vesuvio sembrano suonare più lente oggi, tra le vie di Spaccanapoli e i campi del Cilento risuonano ancora le sue melodie. Perché chi canta la verità del popolo non muore mai.