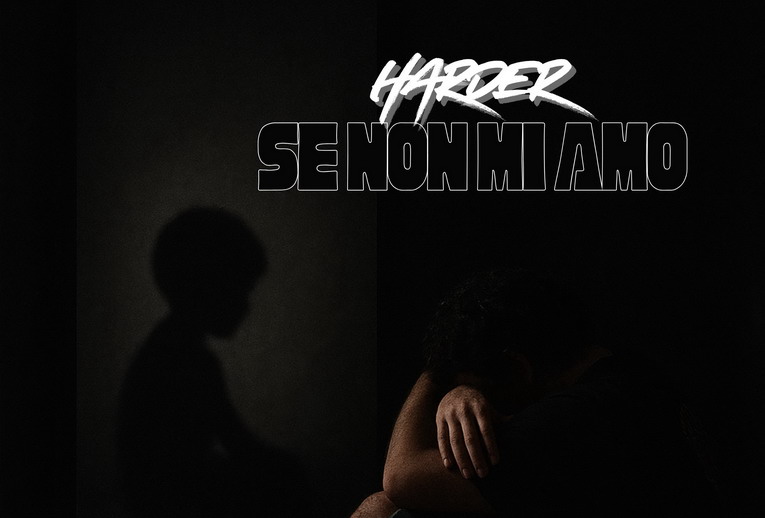Lei si è formata al Centro Sperimentale di Roma e al Digital Filmmaking presso la New York Film Academy. A suo avviso, in America, viene ancora studiato- nelle scuole per attori -il metodo Actor Studio che deriva dal metodo Stanislavskij?
Al centro sperimentale mi sono formata come attrice e alla New York film Academy come regista. Per quello che ho potuto constatare vedendo delle lezioni di recitazione, Stanislaskij rimane comunque una base invariata nei secoli, per quando poi il metodo abbia seguito declinazioni diverse a seconda delle scuole e degli insegnanti.
Come regista in America formano una figura che in Italia non era molto amata fino a poco tempo fa, ovvero la figura del Filmmaker che sa curare in maniera fattiva la lavorazione del film dalla scrittura al montaggio alla post produzione. La contrazione del mercato ha portato poco a poco all’accettazione e alla valorizzazione di questa figura anche in Italia.
Ci parli della sua carriera di attrice: con quale regista si è sentita più a suo agio ?
Con qualsiasi regista avesse una poetica forte, uno sguardo profondo sulle cose. Non amo fare nomi e cognomi, ogni regista a modo proprio e ogni esperienza mi ha lasciato un enorme bagaglio. Francesca Archibugi resta per me una regista di riferimento.
Che intende per “esperta nella valorizzazione della differenze di genere”?
Per esperta nella valorizzazione della differenze di genere si intende un professionista formato a mettere a fuoco e quindi evitare la stereotipia legata al genere nella comunicazione.
Le sue opere letterarie
La mia scrittura nasce quasi sempre da grossi contenitori di ricerca che porto avanti nel tempo e da storie che trovo abbiano la necessità di essere raccontate per porre delle domande nuove. Si scrive spesso per rabbia o per amore. Se la mia necessità di raccontarle si affievolisce nel tempo o con la ricerca, vuol dire che le devo abbandonare. Il primo libro come firma singola è stato “Glass Ceiling, oltre il soffitto di Vetro. Professionalità femminili nel cinema italiano.” (Ed. Edimond) che è stata anche la mia tesi di Laurea in Scienze Politiche, Sociologia del cinema. Dal punto di vista del metodo è stato fondamentale in quel periodo aver seguito per lungo tempo Ascanio Celestini. Il lavoro nasceva da una domanda molto semplice “Perchè per le donne, sia dietro che davanti la macchina da presa, lavorare nel cinema è più difficile?”. Il libro è la risposta che ho cercato di trovare. Poi ha vinto il Premio Edimond e il Premio Pari opportunità, quindi ho firmato subito con Castelvecchi per il primo romanzo “Memorie del cuscino”, nel quale non ho fatto altro che applicare la Sociologia ai sentimenti e vedere cosa succedeva. Anche questo libro ha ricevuto due riconoscimenti, il premio Livio Paoli e il premio Afrodite per le donne nel cinema, quindi Feltrinelli mi ha commissionato di aprire una collana al femminile che ho inaugurato con il manuale “Non ci casco più!” sulle dipendenze affettive. Di fatto la protagonista di “Memorie del cuscino”, Benedetta Abbondanza, era una tragicomica dipendente affettiva. Poi mi sono presa un po’ di tempo per lasciar sedimentare e continuare a far ricerca e il tempo mi ha portata ad “Alice senza meraviglie” (Ed Pendragon), la cui gestazione è iniziata alla fine del primo romanzo e che, in qualche modo, ne è la maturazione. Il racconto è più corale e mi pongo domande nuove su come sono cambiati i rapporti e la nostra società alla luce dei quasi dieci anni che sono passati, con la diffusione capillare delle connessioni virtuali e il precariato che è diventata la normalità esistenziale. Il registro rimane quello “pop” e provocatorio del primo romanzo. Il fatto che io ricorra spesso all’ “ironia” soprattutto nella narrativa è perché ho riconosciuto in me il potere di questo strumento che, come ci ha insegnato Freud, rende accessibili e accettabili aspetti di noi e del sociale che altrimenti non lo sarebbero e cercheremmo solo di evitare o rimuovere.”
Torniamo al Cinema, con gli inizi : “Nerofuori”
Stavo lavorando come attrice ad un mediometraggio di Davide Bini, regista ligure. Parlai a lui della sceneggiatura del corto che avrei voluto girare e chiesi se gli andava di curarne la regia. Mi disse che avevo le idee talmente chiare anche dal punto di vista del linguaggio che oltre che come attrice avrei dovuto anche dirigerlo, lui l’avrebbe prodotto e codiretto. Devo molto a questa sua scelta, non avrei mai deciso da sola di stare sia dietro che davanti la macchina da presa. Facemmo i casting e scegliemmo Francesco Baccini, il cantante, che aveva già fatto un film da protagonista e che nel provino si dimostrò, a differenza degli altri, perfetto per il ruolo. Sul set ha lavorato con me con una generosità, un’apertura e un talento al quale sarà sempre grata. Ero una bambina e decidere di affidarsi a me in quel modo voleva dire aver intuito un potenziale che si sarebbe potuto sviluppare. Sul mio primo set ho avuto la conferma che per me stare davanti e dietro la macchina da presa era naturale, quasi biologico. E quindi questa modalità è diventata una cifra che si ritrova anche nei lavori successivi. D’altra parte per me, nascendo come attrice, è normale scrivere sceneggiature da un punto di vista interno alla storia, da un personaggio che si muove all’interno del racconto. Non è detto poi che sia il protagonista, può essere anche una figurazione, ma resta il fatto che la cosa che mi riesce più semplice è muovere le storia dall’interno.
”Drops” del 2013 : un corto proiettato all’interno della “90 giorni di cinema” di Firenze
che ha ricevuto il Premio miglior corto al Festival “Cinema e psicoanalisi”.
Con la troupe americana l’avevamo definito 30 dollari di gloria, questo mi è costato. Abbiamo fatto un carrello con uno skate che poi ho riportato al negozio di giocattoli facendomi restituire i soldi. E’ stata una bella sfida, volevo focalizzarmi sulla quella discrasia, spesso femminile, che c’è tra quello che pensiamo e quello che comunichiamo. La metafora del “rubinetto” che fa uscire l’inconscio l’ho ottenuta grazie a un sogno che ho fatto una settimana prima di arrivare a New York. Avevo 8 ore per girare, per fortuna l’attrice che maggiormente utilizzo nei miei film (io) è sempre disponibile. Non pensavo avremmo ottenuto un lavoro di senso compiuto, invece ce l’abbiamo fatta.
La sceneggiatura del suo corto “Offline” parla dei rapporti virtuali. Perché la scelta di questo tema?
E’ un tema che mi ossessiona, la solitudine e l’incomunicabilità al tempo della bulimia delle comunicazioni. Basta guardare i tavoli dei ristoranti con i commensali con la testa annegata nel cellulare per capire che ossessiona un po’ tutti.
Quello che mi interessava di più indagare era la superficialità con la quale approcciamo al mezzo virtuale pagandone spesso conseguenze estreme. Su queste non si può intervenire e quindi non mi interessa neanche raccontarle, sono nei fatti di cronaca tutti i giorni. Sull’approccio consapevole al mezzo invece si ed era su questo che mi interessava porre delle domande.
Secondo lei il linguaggio cinematografico in Italia si è involuto?
Assolutamente no, c’è una generazione di registi che stimo tantissimo e che si sono per formati come me al Centro sperimentale, nello stesso periodo in cui mi sono diplomata io, che sta dimostrando quanto il cinema italiano sia ancora ricco di intuizioni e fertile.
L’uso della contaminazione, come lei ha dichiarato, di linguaggi diversi – macchina da presa web came, webcame –gopro e iphone, valorizza l’opera filmica?
Se il racconto lo necessita si, altrimenti no. Il mio ultimo corto tratta di rapporti virtuali che vengono mediati attraverso questi mezzi, non avrei potuto raccontarlo in altro modo senza perdere veridicità e efficacia emotiva.
Il piano sequenza e tutti i repertori del linguaggio cinematografico che hanno fatto la storia del cinema, sono ormai desueti?
Niente è desueto, dipende sempre dalla storia che stiamo raccontando. Quello che interessa a me è il confine tra documentario e finzione, quindi non necessito di virtuosismi tecnici dal punto di vista delle inquadrature. Almeno non fino ad oggi.
”Offline” sarà a Cannes nello Short Film Corner. Cosa si aspetta?
La possibilità di interagire con buyers e distributori internazionali, e così è stato con risultati del tutto inaspettati.
E’ più importante “seguire” la moda o essere originali, rischiando di non accontentare “il mercato”?
Ho sempre fatto scelte sconsigliabili. Non credo né nella moda, né nell’originalità. Credo nella specificità dei linguaggi, qualsiasi linguaggio si stia mettendo in atto. Credo nella conoscenza del mezzo e nella necessità delle storia che tentiamo di raccontare. Se questa necessità non è abbastanza forte o “universale” meglio tacere e fare altro.
E come autori credo bisogna anche avere il coraggio di mettersi in discussione, uscire dalla zona confort delle scelte che abbiamo fatto e che già hanno funzionato, di uscire da temi e modalità che sappiamo hanno avere appeal e accoglienza anche all’estero. Insomma bisogna avere il coraggio di avere coraggio, e questo lo dico soprattutto a me stessa ovviamente. Se poi sia produttori che autori si prendono il coraggio di rischiare è probabile che ne esca un prodotto molto vivo. Non è facile soprattutto viste le condizioni del mercato, ma credo che questa sia la direzione.
Cosa deve cambiare nel cinema italiano per tornare ad essere il cinema dei maestri mondiali?
Il pubblico in sala non è stato molto presente negli ultimi anni, se il cinema non torna ad essere un’esperienza totalmente diversa rispetto ai prodotti che vediamo in tv, o Netflix o internet la sua funzione andrà scomparendo. Bisogna conservare la specificità di questo mezzo, di questo linguaggio e dell’esperienza che deriva dalla sala. Altrimenti perché io spettatore dovrei alzarmi dal divano?
La sua cinematografia del futuro.
Ce la raccontiamo nel prossimo futuro. Sicuramente “Slow food” come qualsiasi cosa abbia tentato di fare. Grazie infinite per l’intervista e per l’interesse!
A Lei!